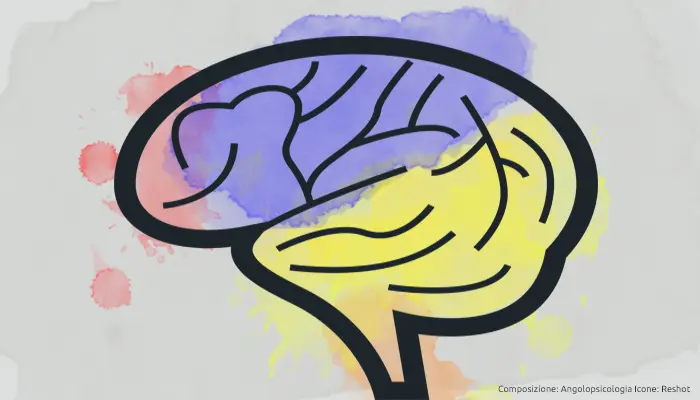
Anche se molte delle teorie freudiane sono state screditate esistono alcune idee che oggi continuano ad essere particolarmente interessanti. Molti anni fa Sigmund Freud propose un meccanismo denominato repressione mediante il quale i desideri e gli impulsi più controversi delle persone verrebbero trasferiti nell’inconscio. La repressione freudiana è un meccanismo di difesa che rappresenta la repressione di ricordi traumatici che però anche dall’inconscio continuerebbero ad influenzare il comportamento delle persone.
Ad ogni modo, ora si sa che il meccanismo mediante il quale si tenta di cancellare alcuni ricordi non è di natura automatica ma i ricordi indesiderati possono essere eliminati in modo cosciente. Un gruppo di ricercatori tedeschi ha riscontrato che, anticipando la repressione dei ricordi, vengono attivati determinati schemi di attività cerebrale che potrebbero anticipare la dimenticanza causata dalla repressione.
Esistono varie ragioni per le quali una persona desidererebbe reprimere determinati ricordi. Forse la ragione più ovvia è che alcuni ricordi possono provocare una reazione emotiva molto forte e quindi, possono produrre, potenzialmente, stress post-traumatico. Un altra causa, non tanto evidente, indica che i ricordi irrilevanti vengono soppressi, soprattutto quando si deve implementare un obiettivo di tipo cognitivo, perchè questa informazione non interferisca nella realizzazione dell’attività.
Ricercatori dell’Universitàdell’Oregon, iniziando con l’utilizzo della risonanza magnetica funzionale, studiarono le basi neurali che intervengono nella soppressione volontaria dei ricordi. Come prima cosa i partecipanti dovevano apprendere coppie di parole e dopo venne loro presentato un compito del tipo: pensare/non pensare. In seguito veniva loro mostrata una delle parole che avevano precedentemente appreso e venne loro chiesto di ricordare la parola associata o che non attivassero la parola corrispondente.
Lo studio mostrò che reprimendo i ricordi vengono attivate le reti diffuse della corteccia frontale e si riduce l’attività nell’ippocampo, zona cruciale per il ricordo. Questi risultati suggeriscono che la soppressione attiva si deve a che i lobi frontali inibiscono l’attivazione dell’ippocampo con la conseguente repressione del contenuto del ricordo.
Un altro studio realizzado dall’Università di Regensburg ricreò le condizioni dell’esperimento anteriore solo che questa volta ai 24 partecipanti venne mostrato su di uno schermo 27 coppie di parole e volti. In seguito venne loro mostrato i volti uno ad uno e venne loro chiesto di ricordare la parola corrispondente. Il risultato fu positivo nell’81% dei casi.
Nella fase pensare/non pensare i partecipanti si concentravano su di una piccola croce nera che appariva sullo schermo appena prima che venisse loro mostrato il volto. Quando la croce diventava verde i partecipanti potevano ricordare la parola, quando diventava rossa non dovevano ricordarla. In questo caso la croce permetteva loro di prepararsi prima dell’attività di repressione.
Curiosamente quando i partecipanti vennero sottoposti ancora una volta alla prova originale i risultati furono più bassi dato che avevano la tendenza a dimenticare quelle parole che venne loro indicato dovevano essere represse.
Così fu possibile osservare con maggior precisione come, 300 millisecondi dopo della presentazione della croce rossa, si attivavano aree della zona frontale destra e del lobo parietale sinistro, i resposabili dell’inibizione del ricordo.
Questa ricerca confermò che il tentativo cosciente di reprimere un informazione può condurre alla sua dimenticanza reale e questo toglierebbe alla repressione il suo velo eminentemente inconscio nel mostrare un altra variante a partire dalla quale si possono dimenticare alcuni ricordi.
Senza dubbio una teoria interessante in merito alla quale c’è ancora molto da scoprire.
Fonte:
Hanslmayr, S. et al (2009). Anticipatory signatures of voluntary memory suppression. Journal of Neuroscience, 29: 2742-2747.
Anderson, et al (2004). Neural systems underlying the suppression of unwanted memories. Science, 303: 232-235.




Lascia un commento