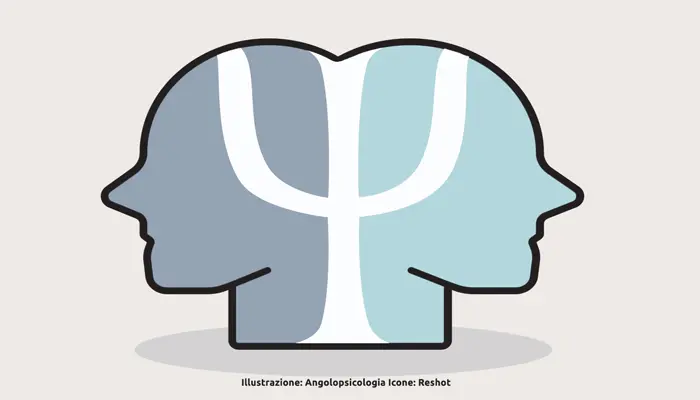
Una delle idee più diffuse in Psicologia, nell’ambiente degli educatori e tra i genitori è che: vidogiochi violenti = comportamenti aggressivi. Comunque, tanto in Psicologia quanto nella vita reale ben poche cose si possono identificare in modo lineare, a questo proposito esistono alcune ricerche che mostrano risultati diversi.
Probabilmente la prima dimostrazione che i videogiochi violenti non conducono necessariamente all’aggressività ed alla irritabilità viene dallo studio condotto dall’Università della Columbia da Anderson e Dill nel 2000.
A questa ricerca parteciparono un totale di 227 studenti che utilizzarono videogiochi violenti e non. In seguito i ricercatori chiesero loro di cambiare gioco, chiesero agli studenti di intraprendere un combattimento reale con persone che si trovavano nella camera accanto. Naturalmente nella camera al lato non vi era nessuno ed il gioco era preparato in modo tale che gli studenti potessero vincere la metà delle volte. I giocatori usavano cuffie che permettevano loro di regolare il livello di rumore che somministravano agli avversari sempre che vincessero. I risultati furono sorprendenti: gli studenti che si erano intrattenuti con i videogiochi violenti prima, somministravano meno rumore rispetto a quelli che avevano giocato con giochi non violenti.
Così, se alcuni giochi violenti possono condurre all’aggressività altri sembrano ridurla, o almeno in via momentanea.
Un altro esperimento simile fu sviluppato nel 2008 da Meier che disegnò un gioco molto semplice per verificare la relazione tra contenuti violenti e condotta aggressiva. Allo stesso parteciparono 81 volontari ai quali furono mostrate parole che apparivano in modo disorganizzato in una parte dello schermo. Loro erano tenuti a cliccare ogni parola, provocando che una nuova parola apparisse al posto suo. Fu loro chiesto di memorizzare le nuove parole per un test di memoria che realizzerebbero in seguito. Comunque il test posteriore non esisterebbe.
Ad alcuni giocatori furono mostrate parole come: “odio” e “assassino” la metà delle volte, quando cliccavano su di esse apparivano altre parole come “promessa” e “condividere” o parole a contenuto neutro. Al secondo gruppo vennero mostrate le stesse parole solo che le parole di contenuto violento furono cambiate con lettere come “ssss” oppure “lllll”.
In seguito fu loro chiesto che giocassero contro un nemico reale e che lo punissero con un certo livello di rumore.
I giocatori che cliccarono su parole aggressive ma ai quali venne chiesto di memorizzare parole di aiuto selezionarono livelli di punizione più bassi per i loro avversari.
La chiave si trova in: vedere parole di contenuto violento seguite da parole che implicano una richiesta di aiuto può ridurre significativamente l’aggressività toccando l’emotività della persona. Addirittura i ricercatori sono giunti a suggerire che giochi di questo tipo potrebbero essere utilizzati in terapie che vanno a trattare persone con problemi d’ira e comportamento aggressivo.
Anderson e Dill sostengono anche che si generano effetti più nocivi attraverso i media, come la televisione, piuttosto che con i videogiochi violenti. Tuttavia, si deve considerare che i videogiochi di carattere esclusivamente violento, soprattutto quando i giocatori sono bambini, possono avere effetti molto negativi sulla formazione della personalità. Queste ricerche, nello stesso modo che uno studio sviluppato per analizzare i possibili livelli di violenza che può generare il leggere la Bibbia, sono realizzati con persone che non sono giocatori quotidiani ed accaniti. Una incidenza diversa si potrebbe avere in quei bambini ed adolescenti che trascorrono buona parte del loro tempo giocando a videogiochi violenti.
Fonti:
Meier, B.; Wilkowski, B. & Robinson, M. (2008).
Bringing out the agreeableness in everyone: Using a cognitive self-regulation model to reduce aggression.
Journal of Experimental Social Psychology, 44 (5), 1383-1387.
Anderson, C. A. & Dill, K. E. (2000) Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings, and Behavior in the Laboratory and in Life.
Journal of Personality and Social Psychology; 78(4): 772-790.




Lascia un commento