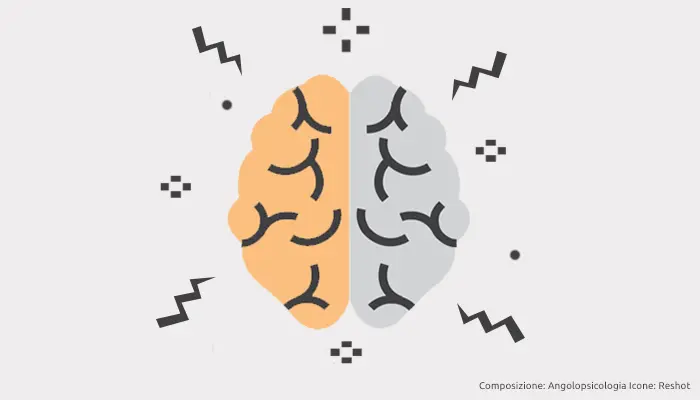
Perché i problemi si moltiplicano, nonostante quanto duramente proviamo a risolverli? Perché appare sempre un problema dopo l’altro, senza darci una tregua?
La risposta, o almeno parte di essa, può trovarsi nel modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni, che spiega perché appaiono continuamente piccoli problemi nella vita che non ci lasciano in pace.
Quando non abbiamo problemi, li inventiamo
Per capire perché i problemi si moltiplicano, lo psicologo David Levari, dell’Università di Harvard, ricorre a una similitudine molto indicativa: il sistema di vigilanza di quartiere. Questo sistema è formato da volontari che si prendono cura del loro vicinato e, quando notano qualcosa di sospetto, chiamano la polizia.
All’inizio, dato che il tasso di criminalità della zona è alto, danno l’allarme quando vedono i segni di possibili gravi crimini. Tuttavia, col tempo i loro sforzi si ripagano e il tasso di criminalità cala notevolmente. A quel punto, è sarebbe normale che il gruppo di volontari abbassi un po’ la guardia e smetta di chiamare la polizia. Dopotutto, i delitti gravi che li riguardavano sono una cosa del passato.
Ma non è questo che succede, almeno nella maggior parte dei casi. I volontari iniziano a chiamare la polizia per fatti insignificanti che considerano “sospetti”, cose che prima non li avevano preoccupati e non rappresentano un pericolo reale per la comunità. Ciò significa che cominciano a vedere pericoli dove non ce ne sono.
Il nostro cervello funziona in modo simile a quel sistema di vigilanza di quartiere.
Quanti meno problemi grandi, tanti più sono i problemi minori
Per analizzare come il nostro concetto di pericolo cambia quando le minacce sono meno comuni, i ricercatori della Princeton University riunirono un gruppo di persone e assegnarono loro un compito semplice: osservare una serie di volti generati dal computer e decidere quali apparivano minacciosi. I ricercatori disegnarono attentamente i volti perché alcuni fossero molto intimidatori e altri innocui.
La cosa interessante è che, quanti meno volti minacciosi si mostravano, tanto più le persone ampliavano la loro propria definizione di minaccia per includere una gamma più ampia di facce. In altre parole, quando non videro più facce minacciose, iniziarono a considerare i volti innocui come potenzialmente pericolosi.
Questo significa che ciò che consideriamo “minacce” o problemi non dipendono sempre da un modello oggettivo ma dal numero di minacce e problemi a cui siamo stati esposti ultimamente.
Questo tipo di incoerenza non si limita ai giudizi sulle possibili minacce. In un altro esperimento, i ricercatori chiesero ai partecipanti di prendere una decisione ancor più semplice: stabilire se i punti colorati che apparivano su uno schermo fossero blu o viola.
Ancora una volta, quando i punti blu divennero rari, le persone iniziarono a segnalare come blu i punti viola. Le persone mantennero questo comportamento anche quando i ricercatori le avvertirono che avrebbero visto pochi punti blu. Questi risultati suggeriscono che si tratta di un comportamento che non sempre controlliamo consapevolmente.
Successivamente, i ricercatori si chiesero se si trattava di un pregiudizio percettivo o influenzava anche altri tipi di giudizio. Progettarono così un esperimento finale in cui chiesero ai volontari di leggere i dati relativi a diversi studi scientifici e decidere quali erano etici e quali no.
I ricercatori identificarono così lo stesso modello. Nella misura in cui alle persone veniva mostrato un numero inferiore di studi poco etici, queste cambiarono il loro metro di valutazione e iniziarono a catalogare come non etici degli studi che in realtà lo erano definitivamente. In altre parole, il semplice fatto di avere a disposizione un numero minore di studi poco etici li rese giudici più severi in fatto di etica.
La “pigrizia” del cervello genera percezioni errate
Perché le minacce e i problemi si moltiplicano mentre diminuiscono? Questo tipo di comportamento è una conseguenza del modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni: confrontiamo costantemente il presente con le nostre esperienze più recenti.
Ad esempio, invece di decidere attentamente se il volto di fronte a noi invia effettivamente segnali minacciosi, lo confrontiamo semplicemente con le facce che abbiamo visto prima. Questo tipo d’analisi comparativa ci porta a trarre conclusioni errate e a trovare minacce o problemi laddove non ce ne sono.
Per il nostro cervello, i confronti relativi richiedono meno energia dei confronti assoluti, come suggeriscono i neuroscienziati dell’Università di Cambridge, quindi tendiamo a privilegiarli invece di limitarci a mettere le cose in prospettiva.
Funzionare con questa “modalità automatica” sempre attiva fa sì che i problemi si moltiplichino perché perdiamo la prospettiva. Quindi, classifichiamo come problemi dei semplici contrattempi. Dobbiamo stare particolarmente attenti a questi “scherzi” che ci gioca il nostro cervello perché possono mettere a rischio il nostro equilibrio mentale, generando delle preoccupazioni inutili.
Fonti:
Levari, D. E. et. Al. (2018) Prevalence-induced concept change in human judgment. Science; 360(6396): 1465-1467.
Levari, D. E. (2018) Why your brain never runs out of problems to find. In: The Conversation.
Niven, J. E. & Laughlin, S. B. (2008) Energy limitation as a selective pressure on the evolution of sensory systems. Journal of Experimental Biology; 211: 1792-1804.
Laughlin, s. B. et. Al. (2001) Energy as a constraint on the coding and processing of sensory information. Current Opinion in Neurobiology; 11(4): 475-480.
Parducci, A. et. Al. (1965) Category judgment: A range-frequency model. Psychological Review; 72(6): 407-418.




Lascia un commento