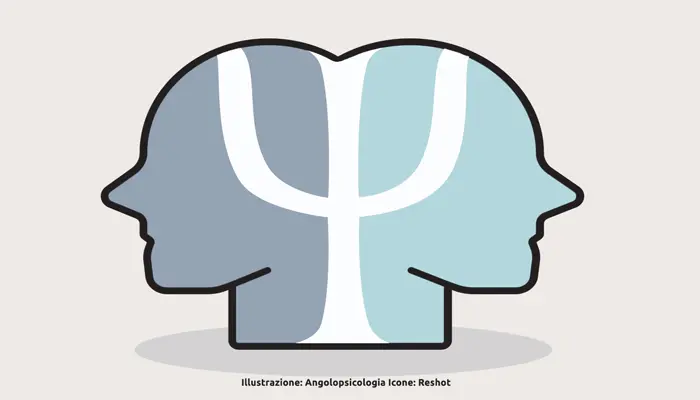
Il fenomeno dell’emigrazione non è nuovo. Quando si scoprì l’America furono migliaia gli europei che si imbarcarono sugli antichi velieri con allo scopo di raggiungere il nuovo continente nella speranza di trovare una vita nuova e maggiori opportunità per realizzare i propri sogni. Oggi le cose non sono cambiate di molto, il fenomeno continua anche se i flussi e le condizioni sono cambiati. Alla base vi è sempre l’insoddisfazione della persona per le condizioni e le opportunità offerti dal paese in cui vive e la speranza di trovare un mondo migliore nel paese dove intende emigrare.
Tuttavia, gli specialisti che studiano attualmente le caratteristiche delle persone che emigrano affermano che queste devono affrontare tutta una serie di requisiti imposti dalla situazione, che molto spesso mettono a dura prova le loro risorse psicologiche, provocando un livello di stress molto superiore a quello che vivevano in precedenza. A questo proposito, Joseba Achótegui, psichiatra e professore dell’Università di Barcellona, ha coniato un nuovo termine per definire gli immigrati illegali (o comunque tutti quelli che si ritrovano in condizioni limite) che soffrono di lunghi periodi di stress: Sindrome di Ulisse o in termini scientifici, Sindrome dell’Immigrante con Stress Cronico.
Come si può intuire, il termine fa riferimento al leggendario Ulisse. Omero lo descriveva nell’Odissea con le seguenti parole: “…e Ulisse passava i giorni seduto sugli scogli, consumandosi a forza di pianti, sospiri e pene, fissando con i suoi occhi il mare sterile, piangendo incessantemente…” In seguito, in un altro passaggio, con l’obiettivo di proteggersi dal terribile ciclope Polifemo risponde così: “chiedi ciclope come mi chiamo…te lo dico. Il mio nome è nessuno e tutti mi chiamano nessuno…”
Forse le cose non sono cambiate così tanto da quei giorni ad oggi dato che attualmente molti emigranti, soprattutto quelli clandestini o illegali, che desiderano sopravvivere, devono essere invisibili, abbandonare la loro identità e la speranza di integrazione sociale. Ovviamente, in questa condizione non è possibile parlare di equilibrio e salute mentale.
I quattro punti di tensione
1. La solitudine, causata dalla separazione dalla famiglia e dagli amici. La nostalgia per tutto ciò che si ha lasciato è difficile da superare, soprattutto quando ci si ritrova in un paese con usi e costumi diversi. Se a questo si aggiunge l’impossibilità di rivedere le persone amate a causa del fatto che le condizioni economiche non lo permettono, il quadro diviene ancor più drammatico. In questo modo, molto spesso la persona sente di essere sprofondata in una specie di vuoto affettivo molto difficile da sopportare.
2. Il fallimento, quando finalmente l’emigrante si rende conto che nel paese in cui è giunto non
esistono tante opportunità come si credeva, e così cominciano ad affiorare la sensazione di fallimento e la disperazione. Molte persone emigrano con l’obiettivo di migliorare economicamente e ottenere un lavoro migliore, ma se dopo un periodo di tempo prudenziale questo obiettivo non si concretizza, si corre il rischio di cadere in una forte depressione pensando che lo sforzo realizzato non è valso la pena.
3. La lotta quotidiana, quando la persona si trasferisce ad un altro paese deve ricominciare la vita da zero. Questo significa trovare un alloggio decente, stabilire nuove abitudini alimentari e
soddisfare altre diverse necessità quotidiane. Inoltre, per ottenere tutto questo ha bisogno di una determinata quantità di denaro che normalmente gli emigranti non hanno (in parte perché accettano lavori mal pagati e in parte perché cercano di inviare la maggior parte di denaro possibile alle loro famiglie). Infine, si ritrovano lottando per sopravvivere giorno dopo giorno in una lotta che consuma, tanto sul piano psicologico che su quello fisico.
4. La paura, la maggioranza degli immigrati illegali entrano nel paese attraverso reti di traffico clandestino che propongono viaggi insicuri durante i quali è anche possibile perdere la vita.
Ovviamente, questo genera paura, ma il problema maggiore risiede nello stress quotidiano che deriva dal timore di essere scoperti e deportati.
Sintomi della Sindrome di Ulisse
Chi soffre di questa condizione manifesta alcuni sintomi che non si riscontrano in tutti gli emigranti, come ad esempio:
– Tristezza: generata dalla sensazione di fallimento e impotenza
– Pianto incontrollabile: che si manifesta in situazioni limite
– Senso di colpa: sensazione di avere causato male ad altri (familiari rimasti nel paese di origine) e colpa per tutto ciò che accade, colpevolizzandosi della situazione attuale. Appaiono
i rimorsi ed i pensieri del tipo: “non dovrei averlo fatto”.
– Tensione e nervosismo: sintomi frequenti che esprimono l’enorme sforzo che si fa per combattere le avversità.
– Preoccupazioni eccessive e ricorrenti: queste persone devono normalmente prendere decisioni importanti in poco tempo, e nello stesso tempo si preoccupano per chi hanno lasciato a casa e per il proprio futuro. Ovviamente, questa situazione è difficile da sopportare quando dura per lungo tempo.
– Insonnia: i pensieri ricorrenti sono i principali responsabili dell’insonnia dato che durante la notte (quando non esistono stimoli esterni che distraggano il pensiero) affiorano i ricordi, e la
solitudine diventa ancor più pesante.
A questi sintomi di indole psicologica si aggiungono altri sintomi fisici come mal di testa e affaticamento.
Ovviamente, la soluzione a questa problematica non si trova solo nelle forze del povero immigrato ma necessita anche di una volontà politica che possa attenuare alcune delle difficoltà che causano il malessere.
Fonte:
Achotegui, J. (2004) Emigrar en situación extrema: el Síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple (Síndrome de Ulises). Norte de Salud Mental; 21: 39–52.




Lascia un commento