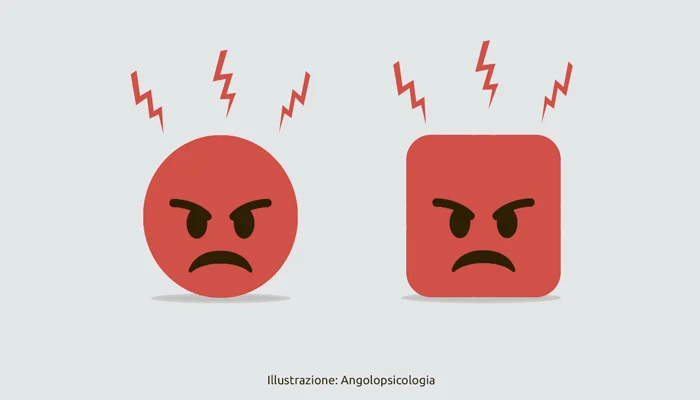
“Lo odio”, “lui mi odia”, “ci odiamo a vicenda”. Le coniugazioni del verbo odiare sembrano moltiplicarsi ovunque. In effetti, sono diventate così comuni che abbiamo persino una legge che criminalizza i crimini d’odio – o forse è proprio quella legge che ha spinto l’odio a livelli stratosferici incoraggiando la tendenza molto umana a fare esattamente ciò che ci è proibito fare. In un modo o nell’altro, potremmo odiare oltre le nostre possibilità.
Cos’è l’odio? Dal significato etimologico al concetto psicologico
Per capire cos’è l’odio dobbiamo risalire alla sua etimologia. Sebbene derivi direttamente dal latino odium, questa parola deriva a sua volta dalla parola greca ὠθέω (otheo), che significa respingere, spingere o allontanare.
Anche se originariamente la sua radice indoeuropea (vad o uad) significava letteralmente stringere o premere. Infatti, nell’antico persiano, l’espressione vad veniva usata per designare un colpo o una discussione.
Tuttavia, sia la radice indoeuropea ad della parola odio che la parola latina edo esprimevano anche un intimo tormento. Pertanto, l’odio ci rimanda a sentimenti di intensa animosità e rifiuto con una forza particolarmente distruttiva.
In psicologia l’odio è un atteggiamento affettivo di ostilità verso qualcosa o qualcuno che, apparentemente, possiede tratti negativi incompatibili con i nostri. Data la sua intensità emotiva, di solito è accompagnato dall’impulso di ferire l’altro o dal desiderio che l’altro faccia del male a se stesso.
Come il resto degli stati affettivi, l’odio può essere un’emozione che appare intensa ma fugace oppure può diventare un sentimento, nel qual caso si instaura e diventa cronico.
Un passo oltre il disgusto e la rabbia
L’odio non è un semplice “non mi piace”. Non esprime solo dispiacere, ma va oltre la rabbia e concentra un alto livello di negatività, come confermato da uno studio realizzato presso l’Università Autonoma di Barcellona. In altre parole: ciò che odiamo è molto più negativo di ciò che non ci piace. Pertanto, l’odio è diversi passi avanti rispetto all’avversione.
Allo stesso modo, supera di gran lunga la rabbia. In effetti, c’è una grande differenza tra rabbia e odio perché la motivazione alla base è diversa. Quando ci arrabbiamo per qualcosa o qualcuno, manteniamo la speranza nel cambiamento. La rabbia, infatti, è un’emozione che ci spinge ad agire per cambiare ciò che ci disturba.
D’altra parte, l’odio è un’esperienza annientante. Siamo convinti che ciò che odiamo non possa cambiare perché lo consideriamo intrinsecamente negativo o addirittura malvagio. Ciò significa che questo sentimento implica implicitamente un giudizio di valore basato su ciò che consideriamo moralmente corretto o meno.
Per questo motivo, gli obiettivi odiati rappresentano una minaccia esistenziale, soprattutto quando ci sentiamo impotenti o percepiamo di avere poco controllo sulla situazione. Di conseguenza, il nostro obiettivo non è cambiare lo stato delle cose – come nel caso della rabbia – ma evitare, ferire o eliminare l’oggetto del nostro odio.
È possibile odiare ciò che non conosciamo bene?
Gordon Allport concepiva l’odio come una forte forma di disgusto con una negatività esacerbata, ma chiarì anche che non può esistere “a meno che non venga violato qualcosa a cui si dà valore”.
Sulla stessa linea, altri psicologi hanno sostenuto che l’odio implica sempre una valutazione negativa di qualcosa o qualcuno sulla base di un giudizio morale. Consideriamo cioè ciò che odiamo moralmente carente o riteniamo che abbia in qualche modo violato il nostro codice etico.
Infatti, uno studio condotto presso l’Università di Haifa nel 2008 sul conflitto israelo-palestinese ha rilevato che l’odio è una reazione diretta alla percezione del danno subito a lungo termine, che noi classifichiamo come intenzionale e ingiusto e deriva da un male intrinseco all’individuo o al gruppo odiato.
Pertanto, l’odio è indissolubilmente legato alla moralità e alla certezza che l’altro è essenzialmente cattivo e non può cambiare. Ciò, ovviamente, richiede una conoscenza minima dell’altro.
Che sia difficile odiare ciò che non conosciamo è supportato da altre ricerche condotte presso le università del Texas e delle Hawaii. Questi psicologi hanno analizzato questo sentimento nella quotidianità chiedendo a un gruppo di persone chi odiavano e perché.
I partecipanti che scrissero sull’oggetto del loro odio si riferivano spesso ad amici, familiari e conoscenti (56%), ma raramente a estranei (4%), suggerendo un profondo legame tra odio e familiarità.
E per attivare uno stato così intenso da scatenare il desiderio di attaccare, sono necessarie una maggiore eccitazione emotiva e una percezione di minaccia personale, come confermarono i ricercatori delle università di Groningen e Amsterdam.
Naturalmente l’odio può anche essere appreso e trasmesso. Dopotutto, viviamo in una cultura di guerra – ben mascherata, ovviamente – che promuove la violenza e nella quale la competizione è lo stile di vita principale.
Ci viene insegnato a competere e a odiare il nemico – che spesso significa chiunque sia diverso o la pensi diversamente – il che lascia poco spazio all’empatia e alla ricerca di ciò che ci unisce. Ecco perché potremmo essere più disposti a odiare e a combattere piuttosto che a risolvere i conflitti attraverso il dialogo.
Ma anche questo non giustifica l’esplosione di odio che stiamo vivendo.
Su Google, la ricerca della parola “odio” restituisce 306 milioni di risultati mentre compassione solo 2,8 milioni. E in realtà stiamo confondendo l’odio con altri sentimenti, come l’animosità, il rifiuto o la rabbia. Stiamo semplicemente odiando oltre le nostre possibilità.
Per contenere l’odio, devi etichettare bene ogni emozione
Nonostante prevalgano i discorsi che incitano all’odio, nemmeno Niccolò Machiavelli la riteneva una buona strategia. Ovviamente neanche vivere consumati dall’odio e dal rancore è una buona idea.
La verità è che c’è molta confusione su cosa sia l’odio e, anche se non bisogna ignorarlo perché, in fondo, è un’emozione con un messaggio da trasmetterci, è necessario capire se è davvero odio allo stato puro o se interpretiamo male ciò che proviamo.
Comprendere esattamente cos’è l’odio ci permetterà di affinare la nostra granularità emotiva ed evitare di alimentare un’emozione che, alla lunga, non porta nulla di buono, né per chi la prova né per chi la riceve, perché come scriveva Charles Darwin, “L’avversione facilmente si trasforma in odio”.
In definitiva, è importante essere consapevoli che, poiché l’odio nasce da una minaccia percepita, spesso è un tentativo di distrarci da sentimenti come impotenza, ingiustizia, inadeguatezza o vergogna. Pertanto, può essere una distrazione da qualche forma di dolore interiore.
La persona consumata dall’odio può arrivare a credere che l’unico modo per riconquistare un certo senso di controllo sul proprio dolore sia attaccare preventivamente gli altri. In questo modo, ogni momento di odio diventa un sollievo temporaneo per la tua sofferenza interiore. Ma in realtà non si tratta altro che di un tentativo di trovare una soluzione che non risolve il problema di fondo. Pertanto, forse dovremmo chiederci: siamo stati indotti a odiare ben oltre le nostre capacità?
Riferimenti:
Petrus, C. et. Al. (2023) The psychology of hate: Moral concerns differentiate hate from dislike. European Journal of Social Psychology; 53(2): 336-353.
Martínez, C. A. (2022) Hate: Toward understanding its distinctive features across interpersonal and intergroup targets. Emotion; 22(1): 46–63.
Halperin, E. (2008) Group-based Hatred in Intractable Conflict in Israel. Journal of Conflict Resolution; 52(5): 10.1177.
Aumer, K. & Hatfield, E. (2007) The Design of Everyday Hate: A Qualitative and Quantitative Analysis. Interpersona; 1(2): 10.5964.




Lascia un commento